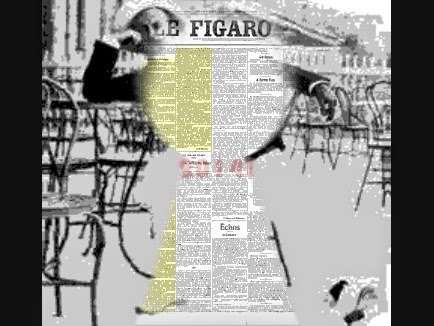Massimo Minella “1914 L’esposizione internazionale di Genova - Il futuro nella storia” ( Deferrari editore)
*REPUBBLICAGENOVA**
Massimo Minella “1914 L’esposizione internazionale di Genova - Il futuro nella storia” ( Deferrari editore). Ecco una sintesi della prefazione al volume scritta da Federico Rampini, editorialista e corrispondente da New York di Repubblica.
È con stupore, ammirazione, e un pizzico di vergogna, che mi sono tuffato nella lettura di questo libro. La vergogna nasce dal fatto che io, nato a Genova, discendente da generazioni di genovesi, ignoravo quasi tutto di questa magnifica pagina di storia della mia città. Non solo ero ignaro dei dettagli sull’Esposizione del 1914, ma divorando questa narrazione mi sono reso conto di quanto poco io sapessi in generale sul dinamismo di Genova all’inizio del secolo scorso.
Le memorie dei miei familiari mi avevano lasciato ben impresso il boom del secondo dopoguerra. Le letture di storia e alcune grandi esposizioni mi avevano istruito sull’Età dell’Oro prolungatasi dal Quattrocento al Seicento.
Ora capisco che il primo Novecento a Genova fu prodigiosamente interessante, e ben venga questo centenario ad accendere la nostra attenzione.
Leggendo la ricostruzione di Massimo Minella a un certo momento ho avuto una sorta di spaesamento spazio-temporale. Ho ri-vissuto l’atmosfera che percepivo alla vigilia dell’Expo di Shanghai nel 2009.
Sul finire dei miei cinque anni di vita in Cina, assistetti al grandioso cantiere di quella esposizione, immediatamente successiva alle Olimpiadi di Pechino. L’alternarsi di quei due eventi aveva un senso preciso. Con i Giochi la Cina si “presentava” al mondo e usava l’evento anche per ridefinire la sua identità nazionale, con delle ardite operazioni di cucitura tra il lontano passato imperiale e l’attuale sistema capital-comunista (nel frattempo mandava l’esercito a reprimere la rivolta tibetana, ma questa è un’altra storia…).
L’Expo di Shanghai ebbe una funzione complementare e diversa. Da un lato fu l’orgogliosa affermazione che la Repubblica Popolare cinese stava progettando una transizione: da fabbrica manifatturiera del pianeta, verso un modello economico più avanzato, pronto a sfidare l’America anche nella gara della modernità.
D’altro lato, confermando che le Esposizioni possono avere una funzione didattica anche nell’era contemporanea, Shanghai venne usata per presentare “il resto del mondo ai cinesi”: ovvero a quelle centinaia di milioni di abitanti delle provincie e delle campagne, che visitando i padiglioni americano o italiano ebbero un’esperienza educativa, di apprendimento, di apertura verso nuovi orizzonti.
Questa rievocazione di Minella mi affascina anche per le analogie che scopro tra la Genova di un secolo fa e la Cina di oggi. Degli anni che ho vissuto a Pechino o esplorando altre potenze emergenti dall’Oriente al Sudamerica, mi rimane impresso un elemento psicologico, di atmosfera: in quei luoghi si respira un’energia umana, un ottimismo diffuso, l’incrollabile fiducia che “il futuro ci appartiene, lo stiamo costruendo, e sarà certamente migliore del nostro passato”.
Ogni volta che torno in quei paesi, nonostante che ci siano stati innumerevoli incidenti di percorso nei rispettivi boom, tensioni sociali, turbolenze e proteste, ritrovo ancora quello spirito positivo. E consiglio ai giovani italiani di inserire nei loro percorsi formativi almeno un pezzo di vita in quei Nuovi Mondi: per capire dove e come si sta plasmando il futuro dell’umanità, e anche per farsi contagiare da quella voglia di fare.
Queste pagine sulla Genova del 1914 sono un tuffo in un passato in cui, come scrive Minella, le Esposizioni universali erano la Rete di oggi, erano i “motori di ricerca” che in poco tempo consentivano di fare il punto sulle nuove conoscenze, gli sviluppi della scienza e della tecnica, i cantieri dell’innovazione, le sfide da affrontare. Cent’anni fa, dunque, Genova era uno di quei laboratori dove si progettava il futuro. Era una delle Silicon Valley all’avanguardia nello sfornare idee visionarie. Era una Shanghai del primo Novecento perché sprigionava ottimismo, energia umana, spirito positivo. Un’immersione in questa rievocazione storica potrebbe far bene ai genovesi di oggi: per riesumare lo spirito dei nonni e dei bisnonni, l’atmosfera di un tempo in cui univano le energie per “fare le cose”, non per bloccarle.
Naturalmente non si può ignorare cosa stava per accadere nel mondo, in quel 1914. La Grande Guerra, oltre all’orrenda carneficina, allo strazio umano e alle distruzioni, sferrò un colpo tremendo all’idea positiva del progresso...
Di recente il museo Guggenheim di New York ha ospitato una grande mostra sul futurismo italiano. E’ impressionante vedere in quella corrente artistica la fusione di alcuni momenti alti della cultura occidentale del primo Novecento (l’eredità del positivismo, il modernismo, la fiducia razionale nella scienza e nella tecnica), perfettamente capaci di coesistere con delle degenerazioni raccapriccianti (l’esaltazione della guerra come “igiene purificatrice dei popoli”, una violenta misoginia, la larvata esaltazione del superuomo) che serviranno da brodo di coltura del fascismo. C’erano allora i germi di un tecno-totalitarismo, che qualche volta riecheggiano in versioni nuove nell’odierna Rete. Davvero, tutto ciò che accadeva in quel 1914 merita la nostra massima attenzione.
***A PARTE la solita retorica ideologica non aggiornata sulla falsa equazione Futurismo Fascismo/totalitarismo del Rampini, mai il comunismo e magari il radioso avvenire di Stalin, pure anch'esso ci pare figlio della Grande Guerra, ecc., prefazione e libro soprattutto assai interessanti. nota di AsinoRosso
Massimo Minella “1914 L’esposizione internazionale di Genova - Il futuro nella storia” ( Deferrari editore). Ecco una sintesi della prefazione al volume scritta da Federico Rampini, editorialista e corrispondente da New York di Repubblica.
È con stupore, ammirazione, e un pizzico di vergogna, che mi sono tuffato nella lettura di questo libro. La vergogna nasce dal fatto che io, nato a Genova, discendente da generazioni di genovesi, ignoravo quasi tutto di questa magnifica pagina di storia della mia città. Non solo ero ignaro dei dettagli sull’Esposizione del 1914, ma divorando questa narrazione mi sono reso conto di quanto poco io sapessi in generale sul dinamismo di Genova all’inizio del secolo scorso.
Le memorie dei miei familiari mi avevano lasciato ben impresso il boom del secondo dopoguerra. Le letture di storia e alcune grandi esposizioni mi avevano istruito sull’Età dell’Oro prolungatasi dal Quattrocento al Seicento.
Ora capisco che il primo Novecento a Genova fu prodigiosamente interessante, e ben venga questo centenario ad accendere la nostra attenzione.
Leggendo la ricostruzione di Massimo Minella a un certo momento ho avuto una sorta di spaesamento spazio-temporale. Ho ri-vissuto l’atmosfera che percepivo alla vigilia dell’Expo di Shanghai nel 2009.
Sul finire dei miei cinque anni di vita in Cina, assistetti al grandioso cantiere di quella esposizione, immediatamente successiva alle Olimpiadi di Pechino. L’alternarsi di quei due eventi aveva un senso preciso. Con i Giochi la Cina si “presentava” al mondo e usava l’evento anche per ridefinire la sua identità nazionale, con delle ardite operazioni di cucitura tra il lontano passato imperiale e l’attuale sistema capital-comunista (nel frattempo mandava l’esercito a reprimere la rivolta tibetana, ma questa è un’altra storia…).
L’Expo di Shanghai ebbe una funzione complementare e diversa. Da un lato fu l’orgogliosa affermazione che la Repubblica Popolare cinese stava progettando una transizione: da fabbrica manifatturiera del pianeta, verso un modello economico più avanzato, pronto a sfidare l’America anche nella gara della modernità.
D’altro lato, confermando che le Esposizioni possono avere una funzione didattica anche nell’era contemporanea, Shanghai venne usata per presentare “il resto del mondo ai cinesi”: ovvero a quelle centinaia di milioni di abitanti delle provincie e delle campagne, che visitando i padiglioni americano o italiano ebbero un’esperienza educativa, di apprendimento, di apertura verso nuovi orizzonti.
Questa rievocazione di Minella mi affascina anche per le analogie che scopro tra la Genova di un secolo fa e la Cina di oggi. Degli anni che ho vissuto a Pechino o esplorando altre potenze emergenti dall’Oriente al Sudamerica, mi rimane impresso un elemento psicologico, di atmosfera: in quei luoghi si respira un’energia umana, un ottimismo diffuso, l’incrollabile fiducia che “il futuro ci appartiene, lo stiamo costruendo, e sarà certamente migliore del nostro passato”.
Ogni volta che torno in quei paesi, nonostante che ci siano stati innumerevoli incidenti di percorso nei rispettivi boom, tensioni sociali, turbolenze e proteste, ritrovo ancora quello spirito positivo. E consiglio ai giovani italiani di inserire nei loro percorsi formativi almeno un pezzo di vita in quei Nuovi Mondi: per capire dove e come si sta plasmando il futuro dell’umanità, e anche per farsi contagiare da quella voglia di fare.
Queste pagine sulla Genova del 1914 sono un tuffo in un passato in cui, come scrive Minella, le Esposizioni universali erano la Rete di oggi, erano i “motori di ricerca” che in poco tempo consentivano di fare il punto sulle nuove conoscenze, gli sviluppi della scienza e della tecnica, i cantieri dell’innovazione, le sfide da affrontare. Cent’anni fa, dunque, Genova era uno di quei laboratori dove si progettava il futuro. Era una delle Silicon Valley all’avanguardia nello sfornare idee visionarie. Era una Shanghai del primo Novecento perché sprigionava ottimismo, energia umana, spirito positivo. Un’immersione in questa rievocazione storica potrebbe far bene ai genovesi di oggi: per riesumare lo spirito dei nonni e dei bisnonni, l’atmosfera di un tempo in cui univano le energie per “fare le cose”, non per bloccarle.
Naturalmente non si può ignorare cosa stava per accadere nel mondo, in quel 1914. La Grande Guerra, oltre all’orrenda carneficina, allo strazio umano e alle distruzioni, sferrò un colpo tremendo all’idea positiva del progresso...
Di recente il museo Guggenheim di New York ha ospitato una grande mostra sul futurismo italiano. E’ impressionante vedere in quella corrente artistica la fusione di alcuni momenti alti della cultura occidentale del primo Novecento (l’eredità del positivismo, il modernismo, la fiducia razionale nella scienza e nella tecnica), perfettamente capaci di coesistere con delle degenerazioni raccapriccianti (l’esaltazione della guerra come “igiene purificatrice dei popoli”, una violenta misoginia, la larvata esaltazione del superuomo) che serviranno da brodo di coltura del fascismo. C’erano allora i germi di un tecno-totalitarismo, che qualche volta riecheggiano in versioni nuove nell’odierna Rete. Davvero, tutto ciò che accadeva in quel 1914 merita la nostra massima attenzione.
***A PARTE la solita retorica ideologica non aggiornata sulla falsa equazione Futurismo Fascismo/totalitarismo del Rampini, mai il comunismo e magari il radioso avvenire di Stalin, pure anch'esso ci pare figlio della Grande Guerra, ecc., prefazione e libro soprattutto assai interessanti. nota di AsinoRosso