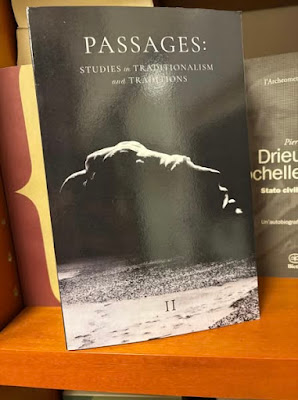https://www.heliopolisedizioni.com/rivista-scuola-romana-di-filosofia-politica.html
- Filosofia della fotografia
- Un saggio di
- Massimo Donà
- rec. di
- Giovanni Sessa
- È nelle librerie, per i tipi di Silvana Editoriale, un volume di Massimo Donà, Filosofia della fotografia. I prodigi di un insospettabile “obiettivo” (pp. 93, euro 18,00). Il libro è arricchito dalla prefazione di Italo Zannier, fotografo di vaglia e storico della fotografia. Le pagine di Donà, mirate a disvelare senso e significato del fotografare, muovono da questa definizione di Zannier: «la fotografia può essere intesa come una tecnica che consente di ottenere immagini figurative di porzioni della realtà, ma […] non necessariamente percepibili dal nostro occhio, mediante gli effetti provocati dalla luce […] su alcune sostanze sensibili» (p. 48). L’argomentare del pensatore veneziano è sostenuto da una non comune conoscenza della letteratura critica in argomento. Egli attraversa e discute, con pertinenza argomentativa e persuasività di accenti, non solo gli aspetti teoretici implicati nell’arte fotografica ma anche, con minuzia di particolari, la sua storia, discussa in relazione ai momenti salienti della rivoluzione tecnico-scientifica e intellettuale della congerie storica nella quale la “scrittura di luce” fece la sua prima, timida, comparsa (in particolare nel capitolo, Verso l’invisibile).
- ...
- Se la fotografia è arte che ha avuto nel Novecento il proprio momento saliente, rileva Donà, essa ha a che fare, come le altre arti del “secolo breve”, con una storia millenaria e, in particolare, con il problema rappresentato dall’irruzione del cristianesimo nella cultura europea. La nostra civiltà è stata l’esito dell’incontro tra il rigido monoteismo ebraico con: «il variegato e popolatissimo Olimpo della cultura greca» (p. 30). Mentre il giudaismo negava la rappresentabilità del divino, la grecità, di contro, è stata attraversata da una polifonia del sacro sostanziata di immagini divine. In tale iter, il dogma trinitario cristiano avrebbe rappresentato una paradossale novità, atta a dire in uno la semplicità: «dell’unico principio quanto la variegata polimorficità di una realtà dai mille volti» (p. 33). Il trinitarismo induceva a pensare tanto la non-raffigurabilità del divino, quanto il suo essere raffigurabile. L’immagine divenne, pertanto, “soglia” che conduceva a un’ulteriorità insondabile, come attestato dalla teologia dell’icona di Florenskij: «l’immagine sarebbe stata ritenuta vera solo nella misura in cui si fosse dimostrata capace di custodire la perfetta invisibilità di quel che essa medesima mai si sarebbe azzardata a mostrare» (p. 34). Il cristianesimo è stato, nel medesimo tempo, iconoclasta e iconofilo.